|
Nella seconda metà degli anni
sessanta l’economia degli Stati Uniti e dell’Europa occidentale
attraversò un brutto periodo: nuove leggi emanate dal Welfare State
britannico e notevoli diseguaglianze tra vari paesi. Le migliori
condizioni di vita presenti in alcuni paesi portarono ad un uso eccessivo
di prodotti non indispensabili e questa abitudine si estese anche a
persone che non se lo potevano permettere; questo fenomeno di spendere per
generi non di prima necessità fu detto “consumismo”. Contro questo
malcostume si schierarono nei paesi industrializzati (Stati Uniti,
Francia, Germania, Italia) gruppi di studenti universitari e delle scuole
superiori, che diedero vita ad un movimento di contestazione, nato nel
1968 e che proseguì anche negli anni ’70. La contestazione giovanile
nata da una esigenza comune tra i vari stati ebbe obiettivi politici
concreti: la lotta alla società consumistica e all’azione repressiva
dell’autorità, rappresentata dallo Stato, dai professori, ecc.
schierarono nei paesi industrializzati (Stati Uniti,
Francia, Germania, Italia) gruppi di studenti universitari e delle scuole
superiori, che diedero vita ad un movimento di contestazione, nato nel
1968 e che proseguì anche negli anni ’70. La contestazione giovanile
nata da una esigenza comune tra i vari stati ebbe obiettivi politici
concreti: la lotta alla società consumistica e all’azione repressiva
dell’autorità, rappresentata dallo Stato, dai professori, ecc.
 Anche
la musica, che ha sempre rappresentato i momenti storici dell’uomo,
risentì degli effetti del movimento studentesco, attraverso le parole e
le note di cantanti quali Joan Baez e Bob Dylan ,
dedicatisi in alcuni momenti della loro vita artistica ad esaltare
l’impegno politico e la giustizia sociale. Anche
la musica, che ha sempre rappresentato i momenti storici dell’uomo,
risentì degli effetti del movimento studentesco, attraverso le parole e
le note di cantanti quali Joan Baez e Bob Dylan ,
dedicatisi in alcuni momenti della loro vita artistica ad esaltare
l’impegno politico e la giustizia sociale.
La contestazione si cominciò a diffondere negli
Stati Uniti: i giovani protestavano per la segregazione razziale, la
diseguaglianza economica e la guerra in Vietnam. Il leader della lotta
alla segregazione razziale fu Martin Luther King (1928 – 1968),
fautore dell’uguaglianza e nemico della superiorità dei bianchi e dei ricchi; contro l’emarginazione dei
neri fu appoggiato dal Presidente Kennedy e dal successore Johnson. Gli
studenti diffusero queste idee con le manifestazioni di piazza, in Tv e
con la musica; fu sicuramente merito loro la decisione nel 1973 del
Governo di Washington di porre fine all’intervento militare in Vietnam.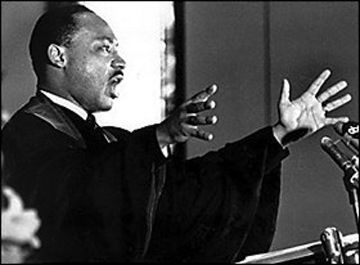
Anche in Europa, a partire dal maggio del 1968 in Francia, la
contestazione giovanile prese piede; la ribellione contro lo stato degli
studenti fu appoggiata anche dai sindacati e il bersaglio, quale
rappresentante delle istituzioni fu il presidente De Gaulle. Lunghi
periodi di violenti scontri con la polizia, scioperi indetti dai sindacati
portarono la Francia sull’orlo della rivoluzione, finchè il generale De
Gaulle sciolse il Parlamento e indisse nuove elezioni nel mese di giugno.
 Contemporaneamente
in Cecoslovacchia l’allora presidente Alexander Dubcek attuò importanti
riforme democratiche (ad
esempio la libertà di stampa), che ottennero
ampio consenso popolare; non altrettanto consenso queste riforme
riscossero nell’Unione Sovietica, guidata da Leonid Breznev, che chiese
ai paesi aderenti al Patto di Varsavia di occupare militarmente la
Cecoslovacchia. In agosto il paese venne occupato e le riforme di Dubcek
vennero annullate; una lunga serie di proteste che degenerarono in
violenti scontri seguirono a questa invasione e va ricordato a tale
proposito l’episodio di un giovane, Jan Palach, che si sacrificò
dandosi fuoco nella piazza principale di Praga il 17 gennaio 1969. Contemporaneamente
in Cecoslovacchia l’allora presidente Alexander Dubcek attuò importanti
riforme democratiche (ad
esempio la libertà di stampa), che ottennero
ampio consenso popolare; non altrettanto consenso queste riforme
riscossero nell’Unione Sovietica, guidata da Leonid Breznev, che chiese
ai paesi aderenti al Patto di Varsavia di occupare militarmente la
Cecoslovacchia. In agosto il paese venne occupato e le riforme di Dubcek
vennero annullate; una lunga serie di proteste che degenerarono in
violenti scontri seguirono a questa invasione e va ricordato a tale
proposito l’episodio di un giovane, Jan Palach, che si sacrificò
dandosi fuoco nella piazza principale di Praga il 17 gennaio 1969.
.....in
Italia
 Il
sessantotto italiano inizia con qualche mese di anticipo sul calendario e
si prolunga ben oltre il 31 dicembre. Il profondo sconvolgimento iniziato in
quell'anno durerà infatti oltre un decennio e coinciderà con una
radicale modernizzazione complessiva del paese. Ad accendere la miccia
sono gli studenti universitari. Nell'autunno del 1967 occupano gli atenei
di tutte le principali città del centro-nord, con la sola esclusione di
Roma. Nel mirino della contestazione ci sono sopratutto il sistema classista del sistema dell'istruzione, denunciata anche da una parte del
mondo cattolico a partire da don Lorenzo Milani autore del severo atto
d'accusa Lettera a una professoressa, e l'autoritarismo proprio
delle università,
interpretato come addestramento a un consenso e a una passività in tutti
i campi,
per nulla limitati al mondo universitario. La
critica del movimento studentesco, i cui principali testi teorici vengono
elaborati nelle università di Pisa, Torino e Trento, si rivolge tanto
contro il sistema capitalistico quanto contro le organizzazioni della
sinistra, accusate di aver rinunciato a
qualsiasi ipotesi di trasformazione. Di fronte al
dilagare delle occupazioni i rettori chiedono l'intervento della polizia.
Occupazioni, sgombri e nuove occupazioni si susseguono. A Torino, Palazzo
Campana, sede delle facoltà umanistiche, viene sgombrato e rioccupato più
volte in un braccio di ferro che si concluderà con un diluvio di denunce
ai danni degli occupanti. Il 2 febbraio viene occupata l'università di
Roma, la più grande Il
sessantotto italiano inizia con qualche mese di anticipo sul calendario e
si prolunga ben oltre il 31 dicembre. Il profondo sconvolgimento iniziato in
quell'anno durerà infatti oltre un decennio e coinciderà con una
radicale modernizzazione complessiva del paese. Ad accendere la miccia
sono gli studenti universitari. Nell'autunno del 1967 occupano gli atenei
di tutte le principali città del centro-nord, con la sola esclusione di
Roma. Nel mirino della contestazione ci sono sopratutto il sistema classista del sistema dell'istruzione, denunciata anche da una parte del
mondo cattolico a partire da don Lorenzo Milani autore del severo atto
d'accusa Lettera a una professoressa, e l'autoritarismo proprio
delle università,
interpretato come addestramento a un consenso e a una passività in tutti
i campi,
per nulla limitati al mondo universitario. La
critica del movimento studentesco, i cui principali testi teorici vengono
elaborati nelle università di Pisa, Torino e Trento, si rivolge tanto
contro il sistema capitalistico quanto contro le organizzazioni della
sinistra, accusate di aver rinunciato a
qualsiasi ipotesi di trasformazione. Di fronte al
dilagare delle occupazioni i rettori chiedono l'intervento della polizia.
Occupazioni, sgombri e nuove occupazioni si susseguono. A Torino, Palazzo
Campana, sede delle facoltà umanistiche, viene sgombrato e rioccupato più
volte in un braccio di ferro che si concluderà con un diluvio di denunce
ai danni degli occupanti. Il 2 febbraio viene occupata l'università di
Roma, la più grande d'Italia. Alla fine del mese, il rettore D'Avack fa intervenire la
polizia. Il giorno dopo, primo marzo, un corteo di protesta arriva a Valle
Giulia, sede della facoltà di architettura e forza i blocchi della
polizia. Gli scontri durano per ore. L'eco è enorme. I giornali, in
edizione straordinaria, parlano di "battaglia". Con i fatti di
Valle Giulia il movimento studentesco si sposta definitivamente dal piano
di una protesta universitaria a quello della contrapposizione decisa con
l'intera società. Nella cultura del movimento confluiscono i
diversi filoni di pensiero critico e di protesta sociale che avevano
costellato gli anni '60: l'elaborazione delle riviste della sinistra non
istituzionale e quella dei vari gruppi cattolici dissenzienti; la critica
alla società dei consumi elaborata dalla Scuola di Francoforte e da
Herbert Marcuse nel suo celebre "L'uomo a una dimensione" e i
fermenti del terzo mondo innescati dalle lotte di liberazione dei popoli ex
coloniali e dalla guerra nel Vietnam; l'"antipsichiatria"
praticata da Franco Basaglia nell'ospedale di Gorizia e il movimento
libertario giovanile sviluppatosi negli anni del "beat
italiano". Inizialmente meno visibile, ma destinata ad affermarsi
sempre di più negli anni successivi, sino a mettere in discussione
l'intera impostazione politica del movimento, è l'originale versione del
femminismo impostata da alcune pensatrici italiane.
Il vento della protesta arriva, senza ancora investirle in pieno, anche
nelle grandi fabbriche del nord. In aprile, a Valdagno, gli operai tessili
della Marzotto si scontrano con la polizia e abbattono la statua di
Gaetano Marzotto, fondatore della dinastia e dell'azienda. In estate un
aspro conflitto operaio si accende al Petrolchimico di Porto Marghera. In
ottobre, alla Pirelli di Milano, nasce il Cub, comitato unitario di base,
prima struttura autonoma operaia svincolata dalla leadership dei
sindacati. Fatto ancor più rilevante, il 7 marzo uno sciopero generale
indetto dai sindacati registra per la prima volta da anni una massiccia
adesione degli operai Fiat, la principale industria del paese. In estate,
con le università chiuse, la contestazione si sposta sul terreno delle
istituzioni culturali. Artisti e studenti interrompono la Biennale e la
mostra del cinema di Venezia. In autunno la palla passa agli studenti medi
che occupano ovunque gli istituti e riempiono le piazze con grandi cortei.
Il 3 dicembre a Roma sfilano 30.000 studenti medi. Alla protesta contro
l'assetto scolastico si somma quella contro la polizia, che il giorno
prima, ad Avola, Sicilia, ha aperto il fuoco contro una manifestazione di
braccianti uccidendone due. Il 1968 si chiude nel sangue. La notte del 31
dicembre gli studenti pisani contestano un veglione di lusso di fronte al
locale versiliese "La Bussola". Uno dei clienti spara ferendo il
sedicenne Soriano Ceccanti, che resterà paralizzato. Nel '69 sono gli
operai a impedire che il movimento degli studenti declini come nel resto
d'Europa. Tra maggio e giugno, alla Fiat, una serie di scioperi spontanei
e improvvisi, proclamati al di fuori del controllo sindacale, paralizza la
produzione per oltre 50 giorni. In prima fila ci sono gli
d'Italia. Alla fine del mese, il rettore D'Avack fa intervenire la
polizia. Il giorno dopo, primo marzo, un corteo di protesta arriva a Valle
Giulia, sede della facoltà di architettura e forza i blocchi della
polizia. Gli scontri durano per ore. L'eco è enorme. I giornali, in
edizione straordinaria, parlano di "battaglia". Con i fatti di
Valle Giulia il movimento studentesco si sposta definitivamente dal piano
di una protesta universitaria a quello della contrapposizione decisa con
l'intera società. Nella cultura del movimento confluiscono i
diversi filoni di pensiero critico e di protesta sociale che avevano
costellato gli anni '60: l'elaborazione delle riviste della sinistra non
istituzionale e quella dei vari gruppi cattolici dissenzienti; la critica
alla società dei consumi elaborata dalla Scuola di Francoforte e da
Herbert Marcuse nel suo celebre "L'uomo a una dimensione" e i
fermenti del terzo mondo innescati dalle lotte di liberazione dei popoli ex
coloniali e dalla guerra nel Vietnam; l'"antipsichiatria"
praticata da Franco Basaglia nell'ospedale di Gorizia e il movimento
libertario giovanile sviluppatosi negli anni del "beat
italiano". Inizialmente meno visibile, ma destinata ad affermarsi
sempre di più negli anni successivi, sino a mettere in discussione
l'intera impostazione politica del movimento, è l'originale versione del
femminismo impostata da alcune pensatrici italiane.
Il vento della protesta arriva, senza ancora investirle in pieno, anche
nelle grandi fabbriche del nord. In aprile, a Valdagno, gli operai tessili
della Marzotto si scontrano con la polizia e abbattono la statua di
Gaetano Marzotto, fondatore della dinastia e dell'azienda. In estate un
aspro conflitto operaio si accende al Petrolchimico di Porto Marghera. In
ottobre, alla Pirelli di Milano, nasce il Cub, comitato unitario di base,
prima struttura autonoma operaia svincolata dalla leadership dei
sindacati. Fatto ancor più rilevante, il 7 marzo uno sciopero generale
indetto dai sindacati registra per la prima volta da anni una massiccia
adesione degli operai Fiat, la principale industria del paese. In estate,
con le università chiuse, la contestazione si sposta sul terreno delle
istituzioni culturali. Artisti e studenti interrompono la Biennale e la
mostra del cinema di Venezia. In autunno la palla passa agli studenti medi
che occupano ovunque gli istituti e riempiono le piazze con grandi cortei.
Il 3 dicembre a Roma sfilano 30.000 studenti medi. Alla protesta contro
l'assetto scolastico si somma quella contro la polizia, che il giorno
prima, ad Avola, Sicilia, ha aperto il fuoco contro una manifestazione di
braccianti uccidendone due. Il 1968 si chiude nel sangue. La notte del 31
dicembre gli studenti pisani contestano un veglione di lusso di fronte al
locale versiliese "La Bussola". Uno dei clienti spara ferendo il
sedicenne Soriano Ceccanti, che resterà paralizzato. Nel '69 sono gli
operai a impedire che il movimento degli studenti declini come nel resto
d'Europa. Tra maggio e giugno, alla Fiat, una serie di scioperi spontanei
e improvvisi, proclamati al di fuori del controllo sindacale, paralizza la
produzione per oltre 50 giorni. In prima fila ci sono gli 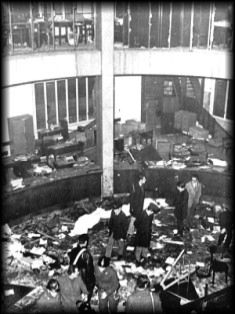 operai meno
qualificati e meno sindacalizzati, spesso immigrati dal meridione, che
danno vita a un'assemblea congiunta con gli studenti. La radicalità dello
scontro si rivela in pieno quando il 3 luglio, in occasione di uno
sciopero
generale cittadino, gli operai torinesi affrontano per 24 ore la polizia.
Il conflitto riprende su larga scala in autunno, quando arrivano a
scadenza i contratti di lavoro che riguardano oltre 5 milioni di operai.
L'"autunno caldo" segna il momento di massimo scontro sociale
nell'Italia del dopoguerra. Gli operai rinnegano la suddivisione della
forza lavoro in fasce diversamente qualificate e chiedono che il salario
sia svincolato dalla produttività. Nascono in questi mesi i principali
gruppi della sinistra extraparlamentare, mentre i sindacati, in un primo
momento colti di sorpresa dalle dimensioni dell'agitazione operaia, danno
vita a strutture unitarie di base, i Consigli di fabbrica. In un clima di
asprezza senza precedenti, il 12 dicembre a Milano una bomba deposta nella
Banca nazionale dell'agricoltura uccide 12 persone. E' l'inizio della
strategia della tensione, una sanguinosa catena di stragi che si
ripeteranno per tutti gli anni '70 e i cui colpevoli non verranno mai
scoperti. Sull'onda della strage di Milano, della quale viene accusato un
gruppo di anarchici poi assolti, i contratti vengono firmati prima della
fine dell'anno. Lo scontro sociale però non si interrompe neppure così.
Negli anni '70 si allargherà ulteriormente, sino a coinvolgere oltre agli
operai e agli studenti, praticamente tutti i settori della società
civile. operai meno
qualificati e meno sindacalizzati, spesso immigrati dal meridione, che
danno vita a un'assemblea congiunta con gli studenti. La radicalità dello
scontro si rivela in pieno quando il 3 luglio, in occasione di uno
sciopero
generale cittadino, gli operai torinesi affrontano per 24 ore la polizia.
Il conflitto riprende su larga scala in autunno, quando arrivano a
scadenza i contratti di lavoro che riguardano oltre 5 milioni di operai.
L'"autunno caldo" segna il momento di massimo scontro sociale
nell'Italia del dopoguerra. Gli operai rinnegano la suddivisione della
forza lavoro in fasce diversamente qualificate e chiedono che il salario
sia svincolato dalla produttività. Nascono in questi mesi i principali
gruppi della sinistra extraparlamentare, mentre i sindacati, in un primo
momento colti di sorpresa dalle dimensioni dell'agitazione operaia, danno
vita a strutture unitarie di base, i Consigli di fabbrica. In un clima di
asprezza senza precedenti, il 12 dicembre a Milano una bomba deposta nella
Banca nazionale dell'agricoltura uccide 12 persone. E' l'inizio della
strategia della tensione, una sanguinosa catena di stragi che si
ripeteranno per tutti gli anni '70 e i cui colpevoli non verranno mai
scoperti. Sull'onda della strage di Milano, della quale viene accusato un
gruppo di anarchici poi assolti, i contratti vengono firmati prima della
fine dell'anno. Lo scontro sociale però non si interrompe neppure così.
Negli anni '70 si allargherà ulteriormente, sino a coinvolgere oltre agli
operai e agli studenti, praticamente tutti i settori della società
civile.
|

