Piemonte: la pagnotta più aristocratica
Nell’antico paese di Savigliano (Cn), fa gli onori di casa la biovona che, tagliata per il lungo, serviva da recipiente per l’insalata. La pagnotta con poca mollica non è l’unica attrazione della capitale mancata, nel 1600 in lizza con Torino per diventare sede del regno di Savoia. Il carattere aristocratico della cittadina si svela nelle case-torri medioevali, nel Teatro Milanollo, nelle antiche dimore nobiliari e nell’Arco di Trionfo, costruito nel XVI secolo per il corteo nuziale del duca Carlo Emanuele I e la sposa Caterina di Spagna.
Il pane di Ferrara ha ricevuto il riconoscimento della tutela europea, l’indicazione geografica protetta. Altri segni di pregio sono quelli lasciati dai duchi d’Este, signori della città. Il loro capolavoro è il Castello del 1300, con quattro possenti torri angolari. Ferrara conserva anche parte delle mura costruite nel 1500 per difendersi da Venezia. Della stessa epoca, il palazzo Ducale e quello dei diamanti, così chiamato per gli 8.500 diamanti di marmo di cui è rivestito. A un passo c’è il Po, da navigare fino al suo delta dove boschi e pinete sono rifugio di uccelli rari.
A Triora (Im), borgo accovacciato su un cucuzzolo della Valle Argentina, si produce una pagnotta rotonda a base di grano saraceno e sale marino, cosparsa di crusca. Il centro custodisce il Castello dei Doria, i vicoli pressoché intatti e i portici. Sono ancora visibili le prigioni in cui venivano interrogate le fattucchiere colpevoli di magia nera al tempo dell’Inquisizione. Nello stesso edificio, il piccolo museo etnografico sulla vita del passato, con sale dedicate alla pastorizia, alla vinificazione e naturalmente alle streghe.
Nel 1200, Altopascio (Lu) ristorava i viandanti nell’Ospedale dei Cavalieri del Tau. Oggi il borgo che ospita la sede dell’Associazione delle Città dei Pani schiera la sua pagnotta senza sale, morbida ma con la crosta croccante. Detto il “Paese dei fornai,” Altopascio mostra i resti dell’ospedale cinto da mura, l’alta torre campanaria e, in centro, botteghe di artigiani con ceramiche e maioliche. Fuori paese si trova il suggestivo laghetto Sibolla, specchio d’acqua con vegetazione rara: ninfee bianche e gialle.
Nella località balneare di Senigallia si produce un pane da farina di grano tenero locale, macinata a pietra, impastata con lievito naturale e sale integrale. La città è suggestiva anche d’inverno con i suoi 13 chilometri di sabbia finissima che portano il nome di Velluto. Ed è anche arte e cultura: conserva palazzi del 1500, opere del Perugino e del pittore Guercino. Insoliti i Musei: La Fenice, con la Pinacoteca d’Arte Sacra; il Museo della Mezzadria nel mondo e quello d’Arte Moderna e dell’ Informazione.
Lazio: un filone protetto
È celebre per il Tappeto Floreale Genzano (Rm), la festa che a Giugno infiora il modo artistico via San Belardi. Ma la sua notorietà è legata anche al filone casereccio, il primo in Europa a ricevere l’indicazione geografica protetta. L’ottima qualità del pane deriva dalla posizione (e del clima) del paese, allungato sul cratere del lago di Nemi. La strada panoramica da cui ci si arriva rivela le bellezze naturali del Parco Regionale dei Castelli Romani di cui Genzano è il centro più popolare. Nell’ambito, vestigia storiche come il palazzo Sforza Cesarini del 1700 e S. Maria della Cima che domina dall’alto l’intero paese e che viene decorata per il Tappeto Floreale.
Musica: un simbolo per noi
adolescenti




Devo essere sincera, la tentazione è quella di raccontarvi cosa è per me la musica, cosa mi fa provare, quale genere mi piace… ma devo scrivere un articolo e non un’autobiografia quindi dovrò parlare in generale!
La musica ormai è diventata quasi il simbolo di noi adolescenti, infatti ognuno sceglie il suo stemma… chi ama il rock, chi la dance, chi la house, chi la latina! Io adoro il rock, almeno questo permettetemelo, non resisto! E’ energico, ribelle e carico di emozioni e grida! Non è bello, però, il fatto che si finisca con il litigare anche per questo… vedo molta gente che si insulta e si fanno brutte discussioni! L’ultima che ho visto mi vedeva praticamente protagonista, ma è un particolare trascurabile, no?
Sì, sì, ci sono dentro anche io, ma ormai è diventata una questione di onore… portare avanti, far conoscere e apprezzare a tutti il rock! Che assurdità, alla fine rimaniamo sempre noi perché il resto del mondo la pensa ciascuno a suo modo. Figuratevi, quando mai qualcuno si allontana dalle sue idee? Oggi siamo un gruppo di soldati disarmati con tante divise diverse!
L’evoluzione dell’uomo
Spesso ci domandiamo: da dove veniamo? È vero che discendiamo dalle scimmie?
Per mezzo dei fossili si può risalire alle specie di ominidi vissute miliardi di anni fa. Il primo fossile abbastanza completo ritrovato in Africa è quello dell’ australopiteco afarensis. Questa specie si differenzia dalle scimmie per la caratteristica di stare in piedi.Una domanda che ci poniamo è:come si arriva al bipedismo?
8 milioni di anni fa esistevano delle scimmie che usavano sia le mani che i piedi, proprio come le scimmie di oggi. Piano piano la foresta diventò savana e quindi non c’erano più tanti alberi e le scimmie cominciarono a passare la maggior parte del loro tempo sul terreno e così divennero bipedi, per poter guardare oltre le erbe alte delle savane e per imparare a cacciare. Ovviamente questo portava a delle conseguenze come ad esempio il fatto che veniva consumata più energia e molto spesso questi esseri non riuscivano a proteggersi dagli altri animali.
Iniziarono le glaciazioni e d’ estate il calore non era sufficiente per sciogliere i ghiacciai e gli ominidi cominciarono a spostarsi dall’Africa verso l’Europa. I Boisei, una specie di australopiteco, riusciva a mangiare le radici delle canne ma, pur essendo vegetariani, non riuscivano a resistere alle termiti, che per loro erano una vera golosità!
Si evolve poi una nuova specie di ominide l’ homo habilis che spostandosi per cercare cibo riuscì a sopravvivere meglio dei boisei e, al contrario di essi mangia per lo più carne. I boisei si sono estinti per non essere riusciti ad adattarsi alla nuova vegetazione o forse per l’ invasione di altre specie di ominidi.
Gli habilis furono i primi a costruire utensili di pietra e così poterono cacciare e cacciando mangiarono sempre più carne che permise l’ aumento del cervello, una volta e mezzo più grande di quello dei boisei.
Poi apparve un’ altra specie di ominide l’ homo ergaster che poi diventerà homo erectus.
Gli ergaster iniziano a comunicare, non hanno più l’aspetto scimmiesco, sono più alti e hanno il cervello più grande, quindi sono più intelligenti. Scoprono una nuova pietra, l’ amigdala, e hanno maggiore capacità di termoregolazione del corpo.
Si spostano, cioè sono nomadi, iniziano ad avere una vita sociale e iniziano a popolare il resto del mondo..
Gli erectus non realizzarono nulla di nuovo perché facevano le cose senza pensarci. Tuttavia scoprirono il fuoco che cambiò anche la loro capacità di adattarsi e li aiutò a diventare ciò che siamo noi oggi, anche perché potevano proteggersi dagli animali e cuocere la carne, fatto importante che cambiò la loro dentatura.
.Appare poi l’ homo heidelbergeisis che non ha immaginazione e neanche il culto dei morti, ma sa curare le ferite di caccia con delle erbe.
Questo ominide si evolverà in due diverse specie, una a sud e una a nord: a sud si evolverà in homo sapiens e a nord in homo di neanderthal.
I neanderthal iniziano a vestirsi e, nonostante le glaciazioni, riescono a vivere grazie al naso che era largo e permetteva nella respirazione l’entrata di più aria.
Nonostante questo non vivevano bene ed erano destinati ad estinguersi
I sapiens, che erano come noi di fisico, riuscivano a vivere meglio con il caldo e a sopportare meglio i raggi del sole, per questo avevano la pelle più scura.
Svilupparono l’ immaginazione, e diffondendosi in tutto il globo, ovunque si spostavano lasciavano dei disegni sulle rocce frutto della loro immaginazione.
Questa specie, che è riuscita a sopravvivere, si è poi evoluta in un nuovo ominide: l’ homo sapiens sapiens che inizia a vivere in villaggi.
Iniziano a essiccare la carne al sole e inventano dei metodi per curare ferite o dolori.
Infine si evolve la nostra specie cioè l’ homo sapiens sapiens sapiens.
Mi auguro che con tutti questi “sapiens” l’uomo moderno sappia combattere la fame nel mondo, le ingiustizie e le guerre.
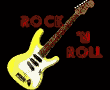
Questo è il secondo anno che le nostre classi si interessano al giornalino web, ma è per me soltanto il primo in cui mi occupo degli articoli.
In questo articolo, voglio parlare della musica che credo sia un punto fermo nella vita dei giovani, ma che svolge un ruolo importante anche nella vita degli adulti. La musica è una cosa molto importante, secondo me. Una canzone può far ricordare situazioni, persone e sentimenti. La musica può essere un passatempo come lo sport, visto che i ballerini danzano a tempo di musica.
Ci sono molti generi di musica e nessuno può essere considerato migliore dell’altro, sono semplicemente diversi. Ognuno sceglie il genere musicale che preferisce, secondo il carattere e la propria personalità: è una cosa personale!


 LA DANZA
LA DANZA



A chiunque, ascoltando la musica, viene voglia di battere le mani o di seguire il ritmo con movimenti del piede: la danza, che all’origine è una serie di movimenti spontanei e naturali, è stata poi modificata in una grande varietà di stili. Alla base di ogni stile sta il piacere di seguire il ritmo. Alcuni graffiti preistorici raffigurano uomini e donne nell’atto di battere le mani o i piedi a tempo di musica. Successivamente la danza, eseguita in coppia o in gruppo ha assunto anche un significato socializzante. Ai passi, ai movimenti e alle danze tipiche del luogo si sono aggiunti anche i costumi, che danno un tocco di inconfondibile folclore e originalità.
IL VALZER
Questa danza nacque in Austria nel XVIII secolo: il compositore Johann Strauss la rese famosa in tutto il mondo; questo ballo particolarmente armonioso ed elegante, viene abbellito da splendidi vestiti lunghi.
LA DANZA MODERNA
La maggior parte delle danze tradizionali ha passi e movimenti standardizzati. La danza moderna invece, è molto più libera. Uno dei primi esempi fu il rock’n roll degli anni ’50. Questo ballo richiede molta agilità e destrezza nei movimenti. I costumi di solito sono colorati, vistosi e morbidi per una migliore capacità di movimento.
DANZE RITUALI
Nelle religioni primitive la danza è sempre stata un elemento importantissimo di ringraziamento e di preghiera verso le divinità. Alcune tribù danzavano per esprimere gratitudine e rispetto verso i propri dei. I pellirossa ballavano davanti ad un falò in cerchio, in questo modo loro eseguivano delle danze particolari. Ad esempio c’era la “danza della fertilità” oppure la “danza della pioggia” che sarebbe chiedere un aiuto verso le loro divinità.
IL BALLETTO MODERNO
All’inizio del XX secolo il balletto moderno iniziò a sciogliersi dai modelli classici, introducendo movimenti più liberi e sciolti. Isadora Duncan fu la pioniera di questo nuovo stile, la cui tecnica venne modificata da una coreografa. La conoscenza e lo studio del balletto classico però, sono sempre alla base della formazione dei balletti moderni.
ANNA PAVLOVA
La russa Anna Pavlova, fu una grandissima ballerina. Cominciò a studiare danza all’età di dieci anni, e raggiunse la sua massima espressione ne “la morte del cigno” creato per lei dal coreografo Fokine.
DANZA MACABRA
Tema iconografico della danza della morte che allarga e rielabora quello dell’incontro tra vivi e morti. Apparve durante il medioevo ottenendo una immediata fortuna e popolarità quanto quello del trionfo della morte. La danza finale che mette in comunicazione le persone potenti e misere. Le figure rispettano un preciso ordine gerarchico che fa capo l’imperatore, seguiti da persone di minore importanza; le figure sono tutte maschili, le figure femminili invece apparvero solo alla fine del 400.
DANZA SULLA CORDA
Questa danza si eseguisce su una corda molto resistente, ad esempio su un filo d’acciaio o di ottone, tutti e tre molto tesi. La danza sulla corda viene praticata da ballerini e acrobati. Sono esercizi di concentramento, destrezza e abilità nel muoversi su un filo. Questi esercizi in allenamento vengono eseguiti a pochi metri da terra, nei circhi invece vengono compiuti a quote molto elevate.
IL BALLETTO
Il balletto è un espressione artistica che si avvale della combinazione di musica. Nacque più di 300 anni fa, come forma di intrattenimento per le famiglie reali, e ancora mantiene i nomi originali francesi per indicare passi e movimenti. Il XIV secolo vide il successo il balletto romantico, come i famosi “la silfide e Giselle”, con le ballerine dai vaporosi tutù. Gli albori del XX secolo salutarono invece la nascita del “balletto russo”, una delle più grandi compagnie di ballo di tutti i tempi. Il balletto è una sequenza di passi rigidamente programmati, il cui insieme si chiama “coreografia”. Quasi tutti i ballerini cominciano ad allenarsi giovanissimi. Infatti il balletto richiede grande spirito di sacrificio e di auto disciplina.
IL “FOLLE VOLO” DI ULISSE e il cammino dell’umanità
Fin dalle origini, l’uomo ha sempre cercato di conoscere meglio il mondo in cui viveva, spinto non soltanto dalla necessità, ma anche dallo spirito di avventura; mosso soprattutto dal desiderio di conoscere tradizioni, lingue, culture e dalla curiosità di esplorare nuovi luoghi. Alcune persone molto coraggiose hanno sfidato e sfidano i limiti posti all’esperienza umana.
Oggi si praticano sport estremi o si svolgono professioni “rischiose” per superare sempre i traguardi già raggiunti da altri.
La memorabile frase di Ulisse:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtude e canoscenza
valida in passato, è ancora di grande attualità. E la storia lo dimostra. Nell’antichità attraverso viaggi avventurosi gli Europei esplorarono il Mediterraneo, le coste Africane spinti dalla curiosità. Cristoforo Colombo scoprì le Americhe.
Oggi, con l’aiuto delle nuove tecnologie, sono stati esplorati gli abissi e i fondali marini, i Poli, le zone selvagge e più nascoste della terra; anche lo Spazio diventa “più vicino” e Marte comincia a svelare la sua identità.
La sete di conoscenza, che ha animato le scoperte più coraggiose ed esaltanti, è strettamente legata alla natura umana. Senza di essa, oggi, non saremmo quello che siamo e l’umanità non avrebbe raggiunto tanti traguardi e evidenziato tanti progressi.
A essa, però, si sono talvolta affiancati, soprattutto in passato, il desiderio di conquista e di possesso e la devastante volontà di sfruttamento (gli Europei nella loro corsa al colonialismo hanno sfruttato gli Indios per ricavare risorse primarie e ricchezze), che hanno creato gravi conseguenze per la natura e per la vita dei popoli tecnologicamente meno evoluti.
Tuttavia, il progresso delle conoscenze ha, in generale, migliorato le condizioni di vita dell’uomo, sconfiggendo superstizioni e ingiustizie. Resta da augurarci che questo miglioramento sia davvero esteso a tutti e che alla “conoscenza” si accompagni sempre la “virtù”.
Diletta Dell’Oglio
HIP HOP
La danza dei ghetti metropolitani
Mi chiamo Chiara e ballo hiphhop da molto tempo ma parlando con la mio amica di questo argomento, mi sono accorta che non conosco a fondo le origini di questa danza… Vorrei approfondire l'argomento anche per voi lettori del giornalino.
Esistono molti tipi di danza hip hop… ma come facciamo a differenziarli??… Riflettiamo su questa cosa.
L'hip hop ha molte radici differenti. La musica, il ritmo e lo spirito derivano dai tamburi africani.
La danza proviene dalletribù africane, dal "Kung Fu" cinese, dalla "Capoiera" brasiliana.
Il BREAKING ebbe origine nei ghetti di New York agli inizi degli anni 70.
Il LOCKING e il POPPING nacquro sulla costa occidentale, in gran parte a Los Angeles, nello stesso periodo.
L'elemento che univa questi stili sotto il comune denominatore di hiphop fu che gli "STREET DANCERS" (I BALLERINI DI STRADA) usavano la danza come sostituta delle risse e dei combattimenti. Invece di ottenere il rispetto con laviolenza, questi ballerini guadagnavano il rispetto con la danza.Due persone con i pugni serrati, pronti a combattere, si trasformarono in due persone che si sfidavano all'interno di un "cerchio", prendendosi in giro a vicenda.
Ciò che rese famoso questa danza fu la possibilità di ottenere il rispetto attraverso essa, tra gli amici, tra le ragazze e tra i gangster, che prima di allora rispettavano solo chi sapeva far uso della forza.
La sfida era l'essenza dell'hiphop ed era anche il motivo percui ipassi eseguiti dai ballerini erano così spettacolari e creativi. Lo stile contava più di ogni altra cosa e non lo sipoteva insegnare,bisognava solo coltivarlo.
Doveva essere divertente, duro e spregievole, per potersi mettere in buona luce nel "cerchio" e far sembrare l'avversario meno bravo.
Quindi l'hiphop affonda le sue radici nel popping, nel locking e nella breaking, ma non si riduce a una sola di queste categorie.La "NEW SCHOOL" hiphop è uno stile che deriva da questi tre tipi di danza na ha un maggiore FLAVAR (stile), se bene conti anche la creatività dei passi.
Esiste un altro stile chiamato "HOUSE", ancora agli inizi ma che i ballerini stanno cercando di promuovere.L'house è una combinazione di stili proveniente da tuuo il mondo: danze africane¸Capoiera, tap, jazz, piroette, popping, locking e breaking.
Lo scopo di questo articolo è far capire ai coetanei che l'hiphop non è semplicemente una danza ma è una filosofia è uno stile di vita. Se sei un ballerino di hiphop lo sai, lo mangi, lo respiri, lo vivi.
Ciascun ballerino deve mantenere vita la coltura dell'hip hop, otre che cercate di migliorare la danza con nuovi passi, stili, concetti e idee……
CHIARA DE LUCA
E VALENTINA POMES 3B
ALESSANDRO MANZONI
Scrittore italiano ( Milano 1785-1873). Figlio di Pietro Manzoni e Giulia Beccaria. Iniziò gli studi a Merate, e li proseguì a Lugano. Quindicenne, compiuti gli studi tornò a vivere nella casa del padre dove la madre non c’era più, fuggita a Londra dopo la separazione. Manzoni sì dedicò alle sue prime composizioni poetiche, imitò Monti e mostrò le sue simpatie per gli ideali democratici e giacobini della rivoluzione. Scrisse sonetti e idilli, Amore a Delia, Contro i poetastri, Al Pagani, Panegirico a Trimalcione, composizioni satiriche, non prive di quel moralismo che fu in seguito la caratteristica della sua arte. Morto nel 1805 a Parigi Carlo Inbonati, Manzoni, che da poco aveva raggiunto la madre, riconquistò il suo affetto e scrisse il carme a lui intitolato. Restò a Parigi fino al 1810, dopo la morte del padre, nominato erede universale, dovette recarvisi con la madre. Durante quell’estate incontrò a Blevio, sulle colline bergamasche, la sedicenne Enrichetta Blondel, figlia di un banchiere ginevrino, e l’anno seguente la sposò, lui ventiduenne, col rito calvinista. Enrichetta intanto, avvicinandosi al Cattolicesimo, aveva fatto battezzare col rito romano la primogenita Giulia e riuscì a convincere il marito a ripetere il matrimonio con rito cattolico. Tra il 1812 e il 1815, Manzoni si dedicò alla stesura dei primi Inni Sacri. Soltanto nel 1822 portò a termine il quinto inno: la Pentecoste. Tra il 1818 e il 1819 Manzoni compose le Osservazioni sulla morale cattolica. Dal 24 Aprile 1821 Manzoni aveva iniziato a Brusuglio la prima stesura del romanzo storico Fermo e Lucia. Se Manzoni nell’affrontare questo genere letterario rispondeva a un gusto allora imperante sulla traccia del successo dei romanzi di W.Scott, altri e più profondi motivi, di natura artistica e morale, maturarono la genesi dell’opera. Con il nuovo titolo: I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Manzoni, il romanzo in tre volumi uscì nel 1827, dopo che dal 1824 al 1826 Manzoni aveva lavorato a ridurlo in linee più essenziali, perfezionando la sua documentazione storica. Raggiunta la celebrità, Manzoni riceveva nella sua casa di via Del Morone i maggiori esponenti della coltura romantica. Nell’anno 1827 Manzoni, scontento, sì recò a Firenze per dedicaresì a una scrupolosa revisione linguistica del romanzo. In questo periodo di intensa attività, una bufera di lutti si abbattè sulla casa di Manzoni: nel 1833 morì Enrichetta, da cui aveva avuto 10 figli. Nel frattempo gli morì la primogenita altre figlie e infine la madre. Si sposò con una contessa vedova e finì il romanzo storico I promessi sposi. Ritornò a Milano dove morì.
Gianluca Ferruggia
LADISPOLI NEL VENTENNIO FASCISTA
L’avvento del fascismo trovò una Ladispoli "adolescente" con circa 300 abitanti fissi, che seguirono quelle vicende come il resto degli italiani in tutta la penisola.
Una sezione del partito Nazionale Fascista organizzava la vita politica della frazione.
La G.I.L. "Gioventù Italiana del Littorio", organizzava i giovani dai 6 ai 18 anni, indirizzandoli allo sport, alla musica (istituì una piccola fanfara) e all’addestramento preliminare.
I ragazzi erano galvanizzati da quel clima di esasperato patriottismo, che veniva inculcato a scuola e durante le adunate del sabato pomeriggio.
Erano fiere delle loro divise da "Figli della lupa", da "Balilla", da "Avanguardisti" o da "Piccole Italiane".
Il lungomare era il teatro dei loro addestramenti guidati da capisquadra e dalle sciarpe del Littorio. Si dice che ad alcuni ragazzi mettessero una fascia al braccio, in modo che capissero quale fosse la destra o la sinistra.
Ogni anno nell’ anniversario della marcia su Roma, il 28 di Ottobre, si commemorava tale data con l’intervento di qualche gerarca e del federale. In corteo, con in testa la fanfara, bandiere e gagliardetti, si trovavano tutti davanti ad un grande palco costruito per l’occasione, dove davano sfoggio della loro preparazione con alza bandiera, saggi ginnici, marciando e cantando. Un anno, il grande palco fu montato in quel grande spazio di terra battuta dove oggi sorge il monumento ai caduti. Erano appena saliti il federale di Civitavecchia Pescosolido, un omone dall’aspetto imponente, tutte le autorità locali e i personaggi in vista al paese:il segretario politico, il maresciallo dei carabinieri, il brigadiere di finanza, il medico condotto, il farmacista, i maestri e le maestre delle scuole elementari, il parroco, gli squadristi, qualche benestante di allora, quando il palco crollò tra lo sgomento generale, provocando qualche ferito e molti ammaccati.
Qualcuno gridò all’attentato, ma in verità il palco era stato costruito male e non collaudato.
Durante le manifestazioni fasciste quei pochi sovversivi (così erano chiamati coloro che non avevano aderito al fascismo), che erano stati confinati a Ladispoli, venivano convocati nella caserma dei carabinieri, dove venivano trattenuti sino alla fine delle predette manifestazioni.
Infine in occasione della visita di Hitler a Furbara,dove avrebbe assistito a delle esercitazioni aviatorie, tutti gli abitanti di Ladispoli furono condotti sulla via Aurelia per far loro sventolare le bandierine di carta italiane e tedesche, ma il corteo di automobili passò così veloce, sia all’andata che al ritorno, che forse nessuno si accorse di loro e delle loro piccole bandierine di carta.
STORIA DI UNA RAPPRESAGLIA
Il 24 settembre del 1943, il comando germanico di Ladispoli, che era installato nell’albergo "Margherita", dopo aver dato l’ordine di evacuare il paese entro 24 ore, costrinse tutti gli uomini a presentarsi al comando.
Si fece una cernita, rimandando a casa i più anziani e trattenendo prigioniere tutte le persone valide che si erano presentate.
Restarono così nelle mani dei tedeschi tutti quei militari che erano riusciti a tornare a casa dopo lo sbandamento dell’8 settembre, alcuni giovani che non aveva ancora 18 anni e alcuni ex militari che erano riusciti a raggiungere il loro paese d’origine.
I prigionieri furono divisi in tre gruppi: uno fu portato a Palidoro, un altro alla torre di Palidoro, il terzo rimase a Ladispoli, dove fu impiegato nella distruzione degli stabilimenti balneari.
A tutti era stato intimato da parte dei tedeschi di non fuggire, pena la delimazione dei compagni rimasti. Ma, malgrado questo avvenimento, dal Presidio di Palidoro fuggi un prigioniero. I tedeschi applicarono subito la rappresaglia, sorteggiando tre prigionieri con il sistema dei fiammiferi senza testa, che venivano fatti estrarre dai prigionieri stessi.
Dei tre sorteggiati 2 erano di Ladispoli: Beniamino Laconi e Guido Lupi. Fecero loro scrivere una lettera, mentre Don Mario Zuccate, avvertito della cosa, accorse subito sul luogo, prese le lettere da consegnare alle famiglie e fece la comunione ai tre malcapitati.
Ma al momento dell’esecuzione, accadde qualcosa che i presenti non compresero perfettamente.
Alcuni dicono che un ufficiale tedesco si addossò la colpa della fuga; altri dicono che in quel momento arrivò una macchina scortata da alcuni motociclisti con a bordo un altro ufficiale tedesco (si dice che fosse Kesserling), il quale fece sospendere tutto.
Guido Lupi però minato nel fisico e da quel giorno la sua salute non migliorò.
L’avvertimento, comunque, cadde nel vuoto, poiché 2 giorni dopo, dal presidio della torre di Palidoro, fuggirono tre prigionieri.
Anche questa volta i tedeschi ricorsero al sorteggio dei fiammiferi dalla testa mozzata e la malasorte scelse il sottotenente Pietro Fumaroli di Ladispoli, Renato Posato, studente universitario, scampato al bombardamento, e Canu G., un ufficiale sardo che era rimasto a Ladispoli.
Ai tre tedeschi non fecero scrivere nessuna lettera non chiamarono nessun prete, non fecero loro nemmeno scavare la fossa perché c’era quella scavata qualche giorno prima dai 22 ostaggi salvati dal sacrificio del brigadiere Salvo D’Acquisto che era sepolto poco distante. I prigionieri furono portati sul ciglio dello scavo e lì una mitragliatrice piazzata falciò le loro giovani esistenze, i corpi caddero nella fossa, i compagni furono chiamati a seppellire i corpi degli amici. Gettarono la terra sui cadaveri con la testa girata altrove, piangendo e riflettendo. Da quel giorno non fuggì più nessuno.
Alessio Giacobini 3B Odescalchi
Una Sinagoga
Centenaria
La Sinagoga è il luogo di culto degli Ebrei. Quella di Roma fu costruita nel
1904 e da poco ha perciò compiuto 100 anni. La Sinagoga si trova nell’ex Ghetto,
cioè vicino al Tevere e di fronte all’Isola Tiberina. Il Ghetto era la zona dove
gli Ebrei dovettero risiedere obbligatoriamente dalla metà del Cinquecento al
1870, data della presa di Porta Pia, in cui anche a Roma, ormai capitale
d’Italia, fu abolito. L’area dell’ex Ghetto comprendeva la zona da Via del
Portico d’Ottavia fino al fiume, ed era una zona malsana, sovrappopolata e
circondata da mura.
Il Ghetto era una delle zone di Roma in cui l’analfabetismo era quasi
inesistente. Questo grazie soprattutto alle 5 scole, le diverse tradizioni
religiose ebraiche giunte a Roma con i vari gruppi israelitici. Per antica
tradizione religiosa nella cultura ebraica è infatti molto importante saper
leggere la Torah, cioè le Sacre Scritture. Anzi, per essere accettati dalla
società adulta i dodicenni devono saper leggere la Torah. Una lettura
difficoltosa perché la Torah è scritta con le sole consonanti e il lettore deve
reinserire le vocali. Dato, però, che non si conoscono le corrette vocali del
nome di Dio, si preferisce usare appellativi come “il Signore” (Adonài), o
altri, per non storpiare il Suo nome.
Una cosa che colpisce molto all’entrata della Sinagoga è che non ci sono
rappresentazioni figurative di santi o di Dio; questo perché non hanno santi e
soprattutto perché la religione proibisce di rappresentare Dio. Nella Sinagoga
ci sono perciò solo simboli come il Menorah (il candelabro dai sette bracci) o
le tavole dei dieci comandamenti.
Alessandro David / Adrian Profir 3°i