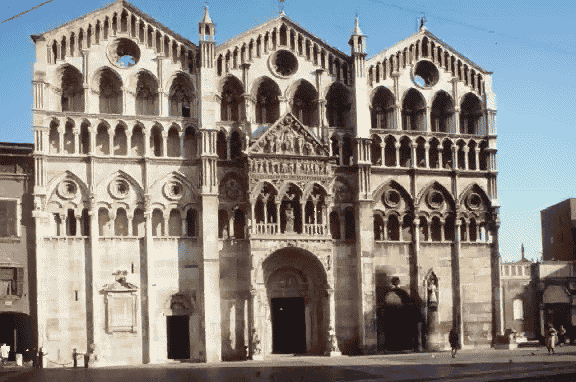
Un’iscrizione in volgare tra le più antiche che si conoscano, già delineata sul mosaico dell’arco del presbiterio ci informa della data e dell’autore della cattedrale ferrarese, non che del suo committente Guglielmo degli Adelardi, la cui immagine viene indicata nella statuetta equestre sull’angolo sinistro della facciata. Sorta in forme non dissimili da quelle del duomo di Modena, la cattedrale di Ferrara ricevette verso la metà del trecento il triplice coronamento ogivale della facciata a loggette sovrapposte, che crea un piacevole contrasto coloristico con la parte inferiore a fasce alterne rosa e grigie. Alla prima fase della costruzione appartengono le fiancate e, sulla fronte, i tre portali, opera di Niccolò, uno dei maggiori seguaci di Wiligelmo, attivo anche nel duomo di Piacenza (portale di destra), in quello di Verona e nella chiesa di San Zeno della stessa città (portali principali).
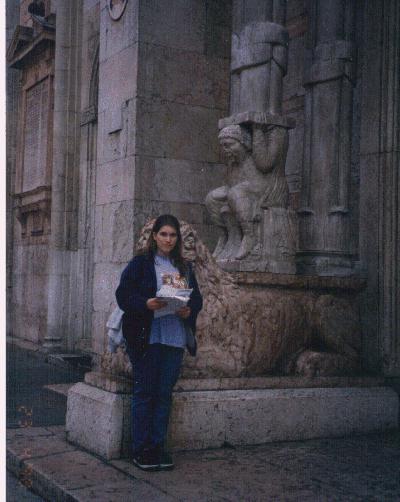
Stupendo a Ferrara il portale centrale, preceduto secondo la consuetudine romanica da un protiro su colonne retto da leoni e cariatidi (copia ottocentesca degli originali conservati nell’atrio della stessa chiesa), munito di un profondo strombo a cordonate digradanti con le figure dei Profeti, dell’Annunziata e di Gabriele, e sormontato da un’architrave con Storie di Cristo e da una lunetta con il San Giorgio titolare della chiesa, la quale, circondata da una lunga iscrizione latina celebrante l’autore, è uno dei pochi brani scultorei in cui sia lecito riconoscere l’intervento diretto di Niccolò, per la particolare nobiltà delle forme e per la sottigliezza quasi pittorica del modellato, che tempera il rude possente plasticismo del maestro Wiligelmo. Sopra il protiro la loggia delle Benedizioni un tempo di semplici linee romaniche, ha avuto molto più tardi, probabilmente verso la metà del XIII secolo le attuali forme gotiche e la stupenda decorazione scultorea con il Giudizio Universale, che, in un’epoca in cui l’arte di Nicola Pisano non si era ancora diffusa nelle zone dominate dalla scultura lombarda, volge i suggerimenti oltramontani a sorprendenti effetti di movimento, di pittorici contrasti di luce e di intensa espressività. Nel vano centrale della loggia la palleggiata e maestosa statua della Madonna, riflette tardi i modi del gotico, è di Cristoforo da Firenze (1427). Di un altro capolavoro della plastica medioevale, la porta dei Mesi, sorgente con strutture di Niccolò sul fianco meridionale della chiesa, non restano, dopo l’inconsulta demolizione settecentesca, che alcune mirabili formelle ora esposte nel museo della cattedrale, nelle quali un sommo maestro seguace dell’Antelami descrive con vigoroso plasticismo e un chiaro, classico senso della narrazione e della composizione le operazioni agricole e i simboli dei vari mesi dell’anno. L’interno della cattedrale con strutture settecentesche (atrio e tre navate su pilastri) del ferrarese Francesco Mazzarelli, una serie di statue di santi in gran parte eseguite dal milanese Andrea Ferreri (XVIII secolo), si riscatta nelle forme pure e grandiose dell’abside rossettiana (1498- 1499), ornata nel catino dell’affresco del Giudizio Universale, l’opera più impegnativa del Bastianino (1580-1583), eseguita , dal suo ritorno dal soggiorno romano, sotto l’evidente suggestione della cappella Sistina. Composta in forma d’altare nel transetto destro è la bronzea Crocefissione e santi (1450-1453) del fiorentino Nicolò Baroncelli scolaro del Brunelleschi che Domenico di Paris completava (1453-1455) con le figure dei Santi Giorgio e Maurelio, collocate ai lati: capolavoro della plastica rinascimentale ferrarese, un tempo sulla demolita iconostasi. Nelle nicchie ovali, sempre nel transetto, sono i busti degli Apostoli e quello del Redentore in terracotta policroma che Alfonso Lombardi con vigoroso senso realistico, modellò per la chiesa della Maddalena a Bologna dove furono presto portati nella cattedrale ferrarese. Le cappelle recano pregevoli dipinti del Garofalo.
(Valentina)