Alla fine del Trecento viene eretto nei pressi della Magna Domus, ma più prossimo al lago, il Castello di S. Giorgio che, posto di fronte all’omonimo ponte, aveva la funzione di presidiare l’accesso alla città da oriente. L’incarico viene affidato a Bartolino da Novara, architetto militare autore del Castello estense di Ferrara, di cui ripete in scala ridotta la tipologia: impianto quadrangolare con cortile al centro e quattro torri angolari pure quadrate. La fabbrica, che può definirsi un castello padano più che lombardo in senso stretto, fu in seguito inclusa nell’ampio complesso della reggia gonzaghesca. Essa si conservò tuttavia sostanzialmente integra, soprattutto all’esterno, in quanto gli altri edifici vi si affiancarono con discrezione, lasciandone liberi tutti e quattro i lati. Gli ambienti interni invece subirono nel tempo profonde modifiche: a distanza di pochi decenni dalla sua costruzione, il marchese Ludovico II avviò una serie di interventi volti a trasformare la funzione difensiva del Castello in quella residenziale.
 Fu così che Andrea Mantegna vi realizzò la famosa Camera degli Sposi. La stanza ha forma quadrata; su due pareti sono dipinti tendaggi di cuoio, sulle rimanenti i tendaggi sono raccolti per lasciare intravedere due scene della vita di palazzo: la Corte di Ludovico Gonzaga, in cui si individuano a sinistra il marchese, nell’atto di ricevere una missiva da parte di un dignitario, quindi la moglie Barbara di Brandeburgo e altri personaggi della famiglia, e l’incontro tra Ludovico Gonzaga e il figlio Francesco nominato cardinale. In questa stanza considerata un caposaldo della pittura quattrocentesca, Mantegna realizza una spazialità intesa in senso scenico-illusionistico. Lo spettatore, entrando, si sente "in presenza" dei personaggi dipinti, per non dire "osservato" da essi. Tale uso illusionistico delle regole prospettiche riceve la più splendida conferma nello spericolato scorcio dal sotto in su che governa l’oculo al centro della volta, raffigurante un parapetto dal quale si affacciano punti e figure femminili, e che tanto successo avrà nella pittura seguente, in particolare in quella barocca. Si tratta delle stesse leggi prospettiche toscane, ma diverso è l’uso che ne viene fatto: in Mantegna la prospettiva, anziché essere intesa come rigore matematico e geometrico, diventa "trompe l’oeil", cioè inganno ottico che tende primariamente a comunicare con lo spettatore illudendolo di una realtà e di uno spazio che invece non esistono. Contemporaneamente all’intervento del Mantegna, nel 1472 il Castello venne fatto oggetto di ristrutturazione. Sotto la direzione di Luca Fancelli, i due lati del cortile interno vennero dotati di un porticato di linee rinascimentali. Le analogie col cortile del palazzo di Urbino e la presenza di Luciano Laurana a Mantova tra il 1465 e il 1466, hanno indotto alcuni studiosi a ipotizzare un apporto dell’architetto dalmata. Con Federico Gonzaga, che succede a Ludovico nel 1478, inizia a profilarsi l’idea di proferire al palazzo dimensioni grandiose, articolandolo in più edifici collegati tra loro.
Fu così che Andrea Mantegna vi realizzò la famosa Camera degli Sposi. La stanza ha forma quadrata; su due pareti sono dipinti tendaggi di cuoio, sulle rimanenti i tendaggi sono raccolti per lasciare intravedere due scene della vita di palazzo: la Corte di Ludovico Gonzaga, in cui si individuano a sinistra il marchese, nell’atto di ricevere una missiva da parte di un dignitario, quindi la moglie Barbara di Brandeburgo e altri personaggi della famiglia, e l’incontro tra Ludovico Gonzaga e il figlio Francesco nominato cardinale. In questa stanza considerata un caposaldo della pittura quattrocentesca, Mantegna realizza una spazialità intesa in senso scenico-illusionistico. Lo spettatore, entrando, si sente "in presenza" dei personaggi dipinti, per non dire "osservato" da essi. Tale uso illusionistico delle regole prospettiche riceve la più splendida conferma nello spericolato scorcio dal sotto in su che governa l’oculo al centro della volta, raffigurante un parapetto dal quale si affacciano punti e figure femminili, e che tanto successo avrà nella pittura seguente, in particolare in quella barocca. Si tratta delle stesse leggi prospettiche toscane, ma diverso è l’uso che ne viene fatto: in Mantegna la prospettiva, anziché essere intesa come rigore matematico e geometrico, diventa "trompe l’oeil", cioè inganno ottico che tende primariamente a comunicare con lo spettatore illudendolo di una realtà e di uno spazio che invece non esistono. Contemporaneamente all’intervento del Mantegna, nel 1472 il Castello venne fatto oggetto di ristrutturazione. Sotto la direzione di Luca Fancelli, i due lati del cortile interno vennero dotati di un porticato di linee rinascimentali. Le analogie col cortile del palazzo di Urbino e la presenza di Luciano Laurana a Mantova tra il 1465 e il 1466, hanno indotto alcuni studiosi a ipotizzare un apporto dell’architetto dalmata. Con Federico Gonzaga, che succede a Ludovico nel 1478, inizia a profilarsi l’idea di proferire al palazzo dimensioni grandiose, articolandolo in più edifici collegati tra loro.
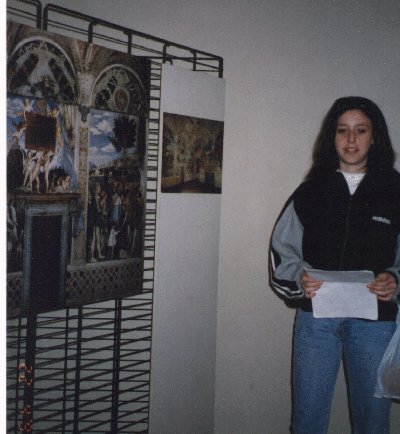 Dietro al palazzo del Capitano si iniziano nel 1480, su disegno di Luca Fancelli i lavori della Domus Nova, architettura di compromesso fra modelli medioevali e nuova cultura umanistica. Nel corso del Cinquecento gli interventi si moltiplicano. Nel 1536 Giulio Romano progetta la cosiddetta Corte Nuova a sud del castello, ampliata dal Bertani e dal Viani nella seconda metà del Cinquecento. Di essa fa parte l’ Appartamento di Troia, così definito a motivo dei dipinti che decorano la volta e le pareti della sala principale: le raffigurazioni, che trattano episodi relativi a quella mitica guerra, furono probabilmente ideate da Giulio Romano, ma eseguite, intorno al 1538, dai suoi allievi. Nel vicino Salone di Manto sono dipinti episodi legati all’origine leggendaria di Mantova, attribuiti a Lorenzo Costa il Giovane, che li avrebbe eseguiti tra il 1576 e il 1579. Intorno al 1538 Giulio Romano porta a compimento la Rustica. Del Bertani è anche la sistemazione del Prato di Castello, che serviva, insieme al Giardino pensile, a collegare il Castello ai palazzi bonacolsiani. Il cortile presenta su tre lati un porticato con archi a tutto sesto retti da colonne binate, mentre il quarto lato si incurva a formare un’esedra, probabilmente con funzione teatrale, attribuita al Viani. Il giardino pensile (1579),che riprende il motivo delle colonne binate, è opera dell’architetto padovano Pompeo Pedemonte. Tra i vari saloni e appartamenti che popolano il vasto complesso edilizio si ricordano anche l’Appartamento di Isabella d’Este e l’Appartamento degli Arazzi, ristrutturato in forme neoclassiche nel 1779 ad opera dell’architetto Paolo Pozzo. Gli arazzi, acquistati intorno al 1530 dal cardinale Ercole Gonzaga, sono ricavati dagli stessi cartoni che Raffaello aveva eseguito per la Cappella Sistina. Fra i tanti dipinti, sovente di grande pregio, si ricorda in particolare la tela di Pietro Paolo Rubens (1605) rappresentante la Famiglia Gonzaga in adorazione della Trinità. Infine merita un cenno particolare il cosiddetto Appartamento dei Nani, opera assai curiosa realizzata all’incirca nel 1614, probabilmente su disegno del Viani. E’ costituito da minuscole stanze, scale e vari ambienti, compresa una cappella, di dimensioni ridotti. Secondo una recente ipotesi, l’Appartamento non era destinato a una corte, a rappresentava un singolare luogo di culto.
Dietro al palazzo del Capitano si iniziano nel 1480, su disegno di Luca Fancelli i lavori della Domus Nova, architettura di compromesso fra modelli medioevali e nuova cultura umanistica. Nel corso del Cinquecento gli interventi si moltiplicano. Nel 1536 Giulio Romano progetta la cosiddetta Corte Nuova a sud del castello, ampliata dal Bertani e dal Viani nella seconda metà del Cinquecento. Di essa fa parte l’ Appartamento di Troia, così definito a motivo dei dipinti che decorano la volta e le pareti della sala principale: le raffigurazioni, che trattano episodi relativi a quella mitica guerra, furono probabilmente ideate da Giulio Romano, ma eseguite, intorno al 1538, dai suoi allievi. Nel vicino Salone di Manto sono dipinti episodi legati all’origine leggendaria di Mantova, attribuiti a Lorenzo Costa il Giovane, che li avrebbe eseguiti tra il 1576 e il 1579. Intorno al 1538 Giulio Romano porta a compimento la Rustica. Del Bertani è anche la sistemazione del Prato di Castello, che serviva, insieme al Giardino pensile, a collegare il Castello ai palazzi bonacolsiani. Il cortile presenta su tre lati un porticato con archi a tutto sesto retti da colonne binate, mentre il quarto lato si incurva a formare un’esedra, probabilmente con funzione teatrale, attribuita al Viani. Il giardino pensile (1579),che riprende il motivo delle colonne binate, è opera dell’architetto padovano Pompeo Pedemonte. Tra i vari saloni e appartamenti che popolano il vasto complesso edilizio si ricordano anche l’Appartamento di Isabella d’Este e l’Appartamento degli Arazzi, ristrutturato in forme neoclassiche nel 1779 ad opera dell’architetto Paolo Pozzo. Gli arazzi, acquistati intorno al 1530 dal cardinale Ercole Gonzaga, sono ricavati dagli stessi cartoni che Raffaello aveva eseguito per la Cappella Sistina. Fra i tanti dipinti, sovente di grande pregio, si ricorda in particolare la tela di Pietro Paolo Rubens (1605) rappresentante la Famiglia Gonzaga in adorazione della Trinità. Infine merita un cenno particolare il cosiddetto Appartamento dei Nani, opera assai curiosa realizzata all’incirca nel 1614, probabilmente su disegno del Viani. E’ costituito da minuscole stanze, scale e vari ambienti, compresa una cappella, di dimensioni ridotti. Secondo una recente ipotesi, l’Appartamento non era destinato a una corte, a rappresentava un singolare luogo di culto.
 Fu così che Andrea Mantegna vi realizzò la famosa Camera degli Sposi. La stanza ha forma quadrata; su due pareti sono dipinti tendaggi di cuoio, sulle rimanenti i tendaggi sono raccolti per lasciare intravedere due scene della vita di palazzo: la Corte di Ludovico Gonzaga, in cui si individuano a sinistra il marchese, nell’atto di ricevere una missiva da parte di un dignitario, quindi la moglie Barbara di Brandeburgo e altri personaggi della famiglia, e l’incontro tra Ludovico Gonzaga e il figlio Francesco nominato cardinale. In questa stanza considerata un caposaldo della pittura quattrocentesca, Mantegna realizza una spazialità intesa in senso scenico-illusionistico. Lo spettatore, entrando, si sente "in presenza" dei personaggi dipinti, per non dire "osservato" da essi. Tale uso illusionistico delle regole prospettiche riceve la più splendida conferma nello spericolato scorcio dal sotto in su che governa l’oculo al centro della volta, raffigurante un parapetto dal quale si affacciano punti e figure femminili, e che tanto successo avrà nella pittura seguente, in particolare in quella barocca. Si tratta delle stesse leggi prospettiche toscane, ma diverso è l’uso che ne viene fatto: in Mantegna la prospettiva, anziché essere intesa come rigore matematico e geometrico, diventa "trompe l’oeil", cioè inganno ottico che tende primariamente a comunicare con lo spettatore illudendolo di una realtà e di uno spazio che invece non esistono. Contemporaneamente all’intervento del Mantegna, nel 1472 il Castello venne fatto oggetto di ristrutturazione. Sotto la direzione di Luca Fancelli, i due lati del cortile interno vennero dotati di un porticato di linee rinascimentali. Le analogie col cortile del palazzo di Urbino e la presenza di Luciano Laurana a Mantova tra il 1465 e il 1466, hanno indotto alcuni studiosi a ipotizzare un apporto dell’architetto dalmata. Con Federico Gonzaga, che succede a Ludovico nel 1478, inizia a profilarsi l’idea di proferire al palazzo dimensioni grandiose, articolandolo in più edifici collegati tra loro.
Fu così che Andrea Mantegna vi realizzò la famosa Camera degli Sposi. La stanza ha forma quadrata; su due pareti sono dipinti tendaggi di cuoio, sulle rimanenti i tendaggi sono raccolti per lasciare intravedere due scene della vita di palazzo: la Corte di Ludovico Gonzaga, in cui si individuano a sinistra il marchese, nell’atto di ricevere una missiva da parte di un dignitario, quindi la moglie Barbara di Brandeburgo e altri personaggi della famiglia, e l’incontro tra Ludovico Gonzaga e il figlio Francesco nominato cardinale. In questa stanza considerata un caposaldo della pittura quattrocentesca, Mantegna realizza una spazialità intesa in senso scenico-illusionistico. Lo spettatore, entrando, si sente "in presenza" dei personaggi dipinti, per non dire "osservato" da essi. Tale uso illusionistico delle regole prospettiche riceve la più splendida conferma nello spericolato scorcio dal sotto in su che governa l’oculo al centro della volta, raffigurante un parapetto dal quale si affacciano punti e figure femminili, e che tanto successo avrà nella pittura seguente, in particolare in quella barocca. Si tratta delle stesse leggi prospettiche toscane, ma diverso è l’uso che ne viene fatto: in Mantegna la prospettiva, anziché essere intesa come rigore matematico e geometrico, diventa "trompe l’oeil", cioè inganno ottico che tende primariamente a comunicare con lo spettatore illudendolo di una realtà e di uno spazio che invece non esistono. Contemporaneamente all’intervento del Mantegna, nel 1472 il Castello venne fatto oggetto di ristrutturazione. Sotto la direzione di Luca Fancelli, i due lati del cortile interno vennero dotati di un porticato di linee rinascimentali. Le analogie col cortile del palazzo di Urbino e la presenza di Luciano Laurana a Mantova tra il 1465 e il 1466, hanno indotto alcuni studiosi a ipotizzare un apporto dell’architetto dalmata. Con Federico Gonzaga, che succede a Ludovico nel 1478, inizia a profilarsi l’idea di proferire al palazzo dimensioni grandiose, articolandolo in più edifici collegati tra loro.
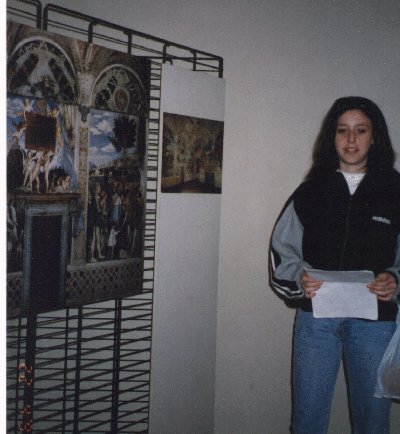 Dietro al palazzo del Capitano si iniziano nel 1480, su disegno di Luca Fancelli i lavori della Domus Nova, architettura di compromesso fra modelli medioevali e nuova cultura umanistica. Nel corso del Cinquecento gli interventi si moltiplicano. Nel 1536 Giulio Romano progetta la cosiddetta Corte Nuova a sud del castello, ampliata dal Bertani e dal Viani nella seconda metà del Cinquecento. Di essa fa parte l’ Appartamento di Troia, così definito a motivo dei dipinti che decorano la volta e le pareti della sala principale: le raffigurazioni, che trattano episodi relativi a quella mitica guerra, furono probabilmente ideate da Giulio Romano, ma eseguite, intorno al 1538, dai suoi allievi. Nel vicino Salone di Manto sono dipinti episodi legati all’origine leggendaria di Mantova, attribuiti a Lorenzo Costa il Giovane, che li avrebbe eseguiti tra il 1576 e il 1579. Intorno al 1538 Giulio Romano porta a compimento la Rustica. Del Bertani è anche la sistemazione del Prato di Castello, che serviva, insieme al Giardino pensile, a collegare il Castello ai palazzi bonacolsiani. Il cortile presenta su tre lati un porticato con archi a tutto sesto retti da colonne binate, mentre il quarto lato si incurva a formare un’esedra, probabilmente con funzione teatrale, attribuita al Viani. Il giardino pensile (1579),che riprende il motivo delle colonne binate, è opera dell’architetto padovano Pompeo Pedemonte. Tra i vari saloni e appartamenti che popolano il vasto complesso edilizio si ricordano anche l’Appartamento di Isabella d’Este e l’Appartamento degli Arazzi, ristrutturato in forme neoclassiche nel 1779 ad opera dell’architetto Paolo Pozzo. Gli arazzi, acquistati intorno al 1530 dal cardinale Ercole Gonzaga, sono ricavati dagli stessi cartoni che Raffaello aveva eseguito per la Cappella Sistina. Fra i tanti dipinti, sovente di grande pregio, si ricorda in particolare la tela di Pietro Paolo Rubens (1605) rappresentante la Famiglia Gonzaga in adorazione della Trinità. Infine merita un cenno particolare il cosiddetto Appartamento dei Nani, opera assai curiosa realizzata all’incirca nel 1614, probabilmente su disegno del Viani. E’ costituito da minuscole stanze, scale e vari ambienti, compresa una cappella, di dimensioni ridotti. Secondo una recente ipotesi, l’Appartamento non era destinato a una corte, a rappresentava un singolare luogo di culto.
Dietro al palazzo del Capitano si iniziano nel 1480, su disegno di Luca Fancelli i lavori della Domus Nova, architettura di compromesso fra modelli medioevali e nuova cultura umanistica. Nel corso del Cinquecento gli interventi si moltiplicano. Nel 1536 Giulio Romano progetta la cosiddetta Corte Nuova a sud del castello, ampliata dal Bertani e dal Viani nella seconda metà del Cinquecento. Di essa fa parte l’ Appartamento di Troia, così definito a motivo dei dipinti che decorano la volta e le pareti della sala principale: le raffigurazioni, che trattano episodi relativi a quella mitica guerra, furono probabilmente ideate da Giulio Romano, ma eseguite, intorno al 1538, dai suoi allievi. Nel vicino Salone di Manto sono dipinti episodi legati all’origine leggendaria di Mantova, attribuiti a Lorenzo Costa il Giovane, che li avrebbe eseguiti tra il 1576 e il 1579. Intorno al 1538 Giulio Romano porta a compimento la Rustica. Del Bertani è anche la sistemazione del Prato di Castello, che serviva, insieme al Giardino pensile, a collegare il Castello ai palazzi bonacolsiani. Il cortile presenta su tre lati un porticato con archi a tutto sesto retti da colonne binate, mentre il quarto lato si incurva a formare un’esedra, probabilmente con funzione teatrale, attribuita al Viani. Il giardino pensile (1579),che riprende il motivo delle colonne binate, è opera dell’architetto padovano Pompeo Pedemonte. Tra i vari saloni e appartamenti che popolano il vasto complesso edilizio si ricordano anche l’Appartamento di Isabella d’Este e l’Appartamento degli Arazzi, ristrutturato in forme neoclassiche nel 1779 ad opera dell’architetto Paolo Pozzo. Gli arazzi, acquistati intorno al 1530 dal cardinale Ercole Gonzaga, sono ricavati dagli stessi cartoni che Raffaello aveva eseguito per la Cappella Sistina. Fra i tanti dipinti, sovente di grande pregio, si ricorda in particolare la tela di Pietro Paolo Rubens (1605) rappresentante la Famiglia Gonzaga in adorazione della Trinità. Infine merita un cenno particolare il cosiddetto Appartamento dei Nani, opera assai curiosa realizzata all’incirca nel 1614, probabilmente su disegno del Viani. E’ costituito da minuscole stanze, scale e vari ambienti, compresa una cappella, di dimensioni ridotti. Secondo una recente ipotesi, l’Appartamento non era destinato a una corte, a rappresentava un singolare luogo di culto.
