Mantova

Città della Lombardia, capoluogo dell'omonima provincia; comune di 63,97 km2 con 54.718 abitanti. È posta a 19 m sulla sponda destra del Mincio (a ca. 20 km dalla sua confluenza nel Po), nel punto in cui il fiume si allarga formando un'ansa pronunciata, che recinge l'abitato da tre lati dando luogo ai cosiddetti Lago Superiore, Lago di Mezzo e Lago Inferiore, separati dai viadotti che portano a Verona e a Legnago. Questa singolare posizione topografica, particolarmente favorevole alla difesa nei secoli scorsi, fu acquistata in età medievale a seguito di una deviazione del Mincio, che prima scorreva probabilmente a una certa distanza dall'abitato, e della formazione di vasti stagni temporanei, che solo in età comunale furono adeguatamente disciplinati e arginati. La città fu protetta dal lato di terra, il più vulnerabile, da poderose fortificazioni, che nel corso dei secoli furono più volte migliorate e rinnovate, ma che costituirono anche un freno al suo sviluppo edilizio a partire dal sec. XVIII, quando venne meno la loro funzione difensiva. Con il prosciugamento del fosso del Paiolo, la città perdette il suo carattere quasi insulare e poté liberamente estendersi verso S, l'unica direzione consentita dalla sua particolare posizione all'interno dell'ansa del Mincio.
Storia della città
Probabilmente di origine etrusca e successivo possesso dei Galli Cenomani, venne occupata dai Romani dopo la vittoria di Casteggio (222 a. C.) e nel 90 a. C. ottenne la cittadinanza romana. Dopo la battaglia di Filippi (42 a. C.), il suo territorio fu in parte confiscato per essere distribuito ai veterani di Augusto. Al crollo dell'Impero, subì le invasioni barbariche: Visigoti, Bizantini, Longobardi e Franchi si alternarono, portando lutti e rovine; città apparentemente libera (fu governata verso l'anno 1000 dalla famiglia dei Canossa), si resse poi a libero comune, prendendo parte alle due Leghe Lombarde (sec. XII e XIII). Nel sec. XIII, dopo un periodo di convulse lotte intestine, passò in potere di Pinamonte Bonacolsi che inaugurò un'era di pace. Nel 1328 venne riconosciuta a Guido Bonacolsi l'ereditarietà della signoria, ma il malgoverno di Passerino, l'ultimo dei Bonacolsi, scontentò i Mantovani; fu eletto perciò, con il consenso del popolo, signore di M., Luigi Gonzaga (1328), la cui famiglia resse per quattrocento anni le sorti della città e del ducato (v. sottolemma). Occupata nel 1797 dai Francesi, annessa al Regno lombardo-veneto nel 1815, divenne uno dei capisaldi del Quadrilatero, ma anche uno dei centri più attivi della cospirazione e della lotta per l'indipendenza e l'unità nazionale. La dedizione alla causa risorgimentale è esemplata dall'episodio dei martiri di Belfiore*, nel cui forte furono giustiziati dagli Austriaci undici patrioti. M. fu liberata l'11 ottobre 1866, quando il presidio austriaco lasciò la città.
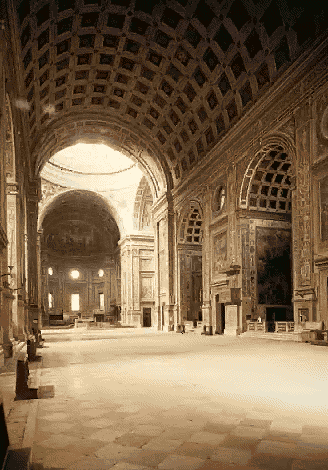
Le più importanti opere d'arte furono realizzate nel periodo di maggior splendore della corte dei Gonzaga che si valse dell'opera dei principali esponenti della cultura rinascimentale, come L. B. Alberti, il Mantegna, L. Fancelli, A. M. Viani, ecc.; nel Cinquecento fu attivo a M. Giulio Romano, che vi profuse la sua opera di architetto e di pittore, caratterizzando inoltre con le sue teorie l'aspetto urbanistico della città. I maggiori monumenti risalenti al sec. XIII sono il Palazzo della Ragione, il Broletto (vicino al quale è la più antica Rotonda di S. Lorenzo, sec. XI), la chiesa di S. Francesco (con affreschi dei sec. XIII-XIV) e quella, più importante, di S. Maria di Gradara, il palazzo Bonacolsi, la Torre della Gabbia (del rifatto palazzo Guerrini, sec. XVI). Il complesso più importante e più noto è costituito dal Palazzo Ducale, che comprende una serie di costruzioni di periodi e stili diversi, erette e trasformate tra il 1290 e il 1707; il nucleo iniziale è costituito dai palazzi dei Bonacolsi (sec. XIII-XIV), detti Palazzo del Capitano e Magna Domus, a cui si aggiunse nel 1380 il castello di S. Giorgio, opera di Bartolino da Novara. Il Palazzo Ducale conserva importanti opere d'arte (celebri sono la Camera degli Sposi affrescata dal Mantegna, 1474; lo studiolo di Isabella Gonzaga; la sala del Pisanello, con ciclo di affreschi di soggetto cavalleresco) ed è sede di una galleria e del Museo Archeologico, comprendente qualche originale greco (testa di stile severo, rilievi votivi), copie romane di statue greche, tra cui l'Apollo di Mantova, ritratti greci e romani (tra cui la testa in bronzo di Arsinoe III), sarcofagi con scene del mito greco e un fregio con scena di combattimento tra Romani e Galli. Ai progetti dell'Alberti appartengono le chiese di S. Sebastiano (iniziata nel 1460) e di S. Andrea (iniziata nel 1470), realizzate da L. Fancelli. Capolavoro di Giulio Romano è il Palazzo del Te (1525-35) con l'importante ciclo pittorico della Sala di Psiche. Allo stesso artista appartengono la ricostruzione del duomo (1545) con la Cappella dell'Incoronata dell'Alberti, la ricostruzione della chiesa dell'antica abbazia di S. Benedetto Po (1539-42). Importanti esempi di architettura del sec. XV sono la Torre dell'Orologio, la casa del Mantegna, le chiese di S. Maria delle Grazie e di S. Maria degli Angeli, il palazzo Andreasi, l'Università dei Mercanti (con testimonianza di affreschi del Pordenone sulla facciata). Al Settecento appartengono le architetture dell'Accademia Virgiliana (1773; G. Piermarini) e del sottostante "Teatro Scientifico" del Bibiena (1769).M. è inoltre celebre per la manifattura di arazzi che, fondata nel 1419 da Jean de France, fu attiva fino al 1478. La manifattura, cui aveva dato cartoni anche il Mantegna, risorse nel 1539 su iniziativa dei Gonzaga che chiamarono da Ferrara Nicola Karcher con 10 lavoranti. Per la mancanza di notizie documentarie è incerta l'attribuzione tra M. e Ferrara di alcune note serie tra cui i Giochi di putti (Milano, Museo del Duomo) su disegno di Giulio Romano e la Storia di Mosé (Milano, Museo del Castello).
(Luana )