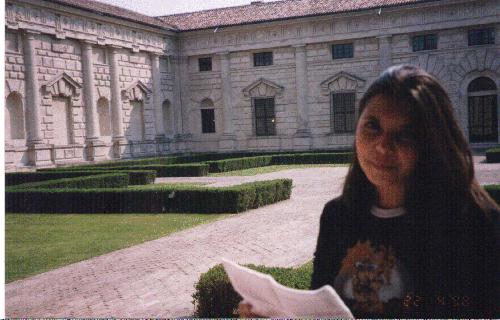

Grande villa suburbana costruita da Giulio Pippi, meglio noto come Giulio Romano (1492\99-1546). Chiamato a Mantova nel 1524 da Federico II Gonzaga, Giulio Romano divenne in quel piccolo centro un protagonista indiscusso, così come il suo grande maestro, Raffaello, lo era stato a Roma. Nel grandioso programma di rinnovamento, che voleva Roma come modello per Mantova, emerge per imponenza di concezione e per fascino intellettuale il Palazzo del Te' (1525-34). Qui Giulio, in un certo senso, rappresenta tutti i problemi della maniera, impostando e complicando i temi di una cultura già penetrata nella sua fase romana. Giulio libera, negli infiniti pretesti della progettazione architettonica e della decorazione pittorica, una miniera di spregiudicati mezzi espressivi. In questa ricerca continua, quasi ai limiti dell'ossessione, tende allo spasimo le variabili espressive dei linguaggi manieristi e scopre del tutto i nervi delicati e le articolazioni indebolite di un classicismo che ormai è diventato luogo di memoria. Un esempio è il triglifo che si stacca dal fregio e precipita, spezzando così la logica dell' "ordine". Nella facciata verso il cortile del lato ovest, lo "scherzo" del triglifo che, slittando verso il basso, annulla la continuità "reticolare" dell'ordine, assume un significato ironico e intellettualmente allusivo. Ma segna anche i momenti di una libertà compositiva assoluta, rispetto al dogma cristallizzato dei linguaggi classici del secondo Rinascimento.
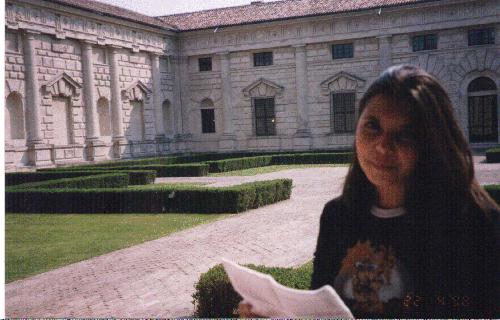
 Ma la sala più nota del Palazzo Te è sicuramente la sala dei Giganti dipinta da Giulio Romano e Rinaldo Mantovano con la Vittoria di Giove sulla folle presunzione dei Titani; la scena mirava a esaltare la grandezza di Carlo V di fronte alla presunzione dei suoi nemici. Nella sala dei Giganti il programma iconografico culmina in una potente struttura illusionistica. La forza che si genera dalla sua sostanza pittorica, imponente e sontuosa, è tremenda nella sua energia di pura forma. Giove, assiso sull'Olimpo, scaglia fulmini tremendi che fanno crollare i palazzi dei giganti in una rovina senza scampo. Il tutto in un ambiente fisico reale - la stanza - quasi privo di luce e dove, a causa della continuità suggerita dallo smusso degli angoli del pavimento, delle pareti e del soffitto, si crea una voluta ambiguità che spiazza l'osservatore coinvolto nella scena caotica, ma anche stupito dal virtuosismo del pittore. Il fragoroso crollo della pesante architettura travolge i giganti sconfitti, ma poi continua la sua inarrestabile caduta sugli attoniti spettatori che, proiettati nella finzione, dal basso osservano la scena. In fondo, nell'invenzione illusionistica, in tutta quella catastrofe, in quei volti stralunati, nelle architravi che rovinano, nel digrignare dei denti è possibile anche un'altra lettura: quella dello "scherzo", dell'ironia che ancora più causticamente svela i meccanismi dell'artificio di un puro e semplice spettacolo.
Questa fabbrica, una sorta di rediviva villa suburbana di respiro classico, ad un solo piano per inserirsi meglio nel piatto paesaggio dell'isola del Tejeto (da cui il nome), possiede una struttura estremamente sofisticata. Quattro lunghi corpi racchiudono un vasto cortile, al quale segue un ampio giardino su cui si aprono le stalle, ed infine un'ampia esedra che conclude la scenografia dell'impianto. ora basta confrontare i quattro corpi dell'edificio per accorgersi della loro apparente simmetria e delle intenzionali contraddizioni compositive che contestano il vocabolario classico dell'architettura. E' come adoperare una rigorosa geometria in una sintassi completamente sovvertita, cosicché le frasi che ne vengono fuori possono apparire o vaneggiamenti di pazzi o divertimenti di raffinati enigmisti.
In questo liberarsi della forma, il controllo di Giulio arriva sempre un momento prima dello smarrimento e scopre il gioco velato. Perciò le chiavi di volta che "scivolano" nello spazio dell'arco, o i triglifi che si "abbassano" nell'architrave rivelano chiaramente il loro "gioco", perché, se così non fosse, anche la struttura che da loro dipende non potrebbe esistere e sostenersi. E saranno proprio queste "eresie", forse non molto apprezzate dal pubblico ortodosso, ad intrigare tutta una generazione di architetti della maniera.
Ma la sala più nota del Palazzo Te è sicuramente la sala dei Giganti dipinta da Giulio Romano e Rinaldo Mantovano con la Vittoria di Giove sulla folle presunzione dei Titani; la scena mirava a esaltare la grandezza di Carlo V di fronte alla presunzione dei suoi nemici. Nella sala dei Giganti il programma iconografico culmina in una potente struttura illusionistica. La forza che si genera dalla sua sostanza pittorica, imponente e sontuosa, è tremenda nella sua energia di pura forma. Giove, assiso sull'Olimpo, scaglia fulmini tremendi che fanno crollare i palazzi dei giganti in una rovina senza scampo. Il tutto in un ambiente fisico reale - la stanza - quasi privo di luce e dove, a causa della continuità suggerita dallo smusso degli angoli del pavimento, delle pareti e del soffitto, si crea una voluta ambiguità che spiazza l'osservatore coinvolto nella scena caotica, ma anche stupito dal virtuosismo del pittore. Il fragoroso crollo della pesante architettura travolge i giganti sconfitti, ma poi continua la sua inarrestabile caduta sugli attoniti spettatori che, proiettati nella finzione, dal basso osservano la scena. In fondo, nell'invenzione illusionistica, in tutta quella catastrofe, in quei volti stralunati, nelle architravi che rovinano, nel digrignare dei denti è possibile anche un'altra lettura: quella dello "scherzo", dell'ironia che ancora più causticamente svela i meccanismi dell'artificio di un puro e semplice spettacolo.
Questa fabbrica, una sorta di rediviva villa suburbana di respiro classico, ad un solo piano per inserirsi meglio nel piatto paesaggio dell'isola del Tejeto (da cui il nome), possiede una struttura estremamente sofisticata. Quattro lunghi corpi racchiudono un vasto cortile, al quale segue un ampio giardino su cui si aprono le stalle, ed infine un'ampia esedra che conclude la scenografia dell'impianto. ora basta confrontare i quattro corpi dell'edificio per accorgersi della loro apparente simmetria e delle intenzionali contraddizioni compositive che contestano il vocabolario classico dell'architettura. E' come adoperare una rigorosa geometria in una sintassi completamente sovvertita, cosicché le frasi che ne vengono fuori possono apparire o vaneggiamenti di pazzi o divertimenti di raffinati enigmisti.
In questo liberarsi della forma, il controllo di Giulio arriva sempre un momento prima dello smarrimento e scopre il gioco velato. Perciò le chiavi di volta che "scivolano" nello spazio dell'arco, o i triglifi che si "abbassano" nell'architrave rivelano chiaramente il loro "gioco", perché, se così non fosse, anche la struttura che da loro dipende non potrebbe esistere e sostenersi. E saranno proprio queste "eresie", forse non molto apprezzate dal pubblico ortodosso, ad intrigare tutta una generazione di architetti della maniera.
(Sara)