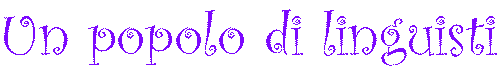

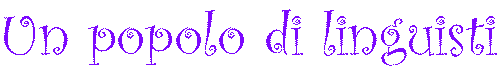

| Quante volte siete entrati in una gastronomia ed avete chiesto della “glicerizia”? “Mai!” è quello che già sento fuoriuscire all’unisono dalle vostre bocche, quasi vi steste discolpando da una qualche accusa fattavi! Ed invece lo avete chiesto più di quanto possiate mai immaginare, naturalmente se siete degli amanti della “liquirizia”! Infatti, si tratta proprio della fortunata radice che ha incontrato i gusti di molti, anche se a sentire quel nome strano, non sembrava si stesse parlando proprio di lei! Ed in questo articolo è mia precisa intenzione parlarvi di quello che a scuola dovrebbe essere argomento di maggiore studio: l’etimologia.Cos’è l’ ”etimologia”? L’etimologia è la ricerca del vero significato di una parola, del suo |
 |
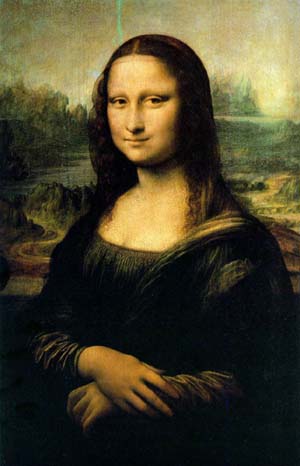 |
“stumon”, vale a dire, in termini
propriamente linguistici, della “ragione vera della forma di una parola”.
Fare etimologia non è, però, cosa facile, soprattutto se
intendiamo farla correttamente. Lo studio della lingua latina ci ha insegnato
(ed insegna) che la maggior parte del nostro lessico proviene da lei, nonché,
chiaramente, dalla sua “sorella greca”. E proprio questa constatazione
ci spinge a supporre chissà mai quali assurde e contorte origini
per parole di cui non conosciamo il significato, che però abbiamo
la presunzione di ricavare per logica (?!) dalla forma della parola in
questione a noi sconosciuta, quando basterebbe consultare un dizionario
della lingua italiana.
Ed eccoci a commettere quello che può essere considerato il tipico errore degli improvvisati linguisti da un momento all’altro per necessità, o meglio ancora per pigrizia: cercare un riscontro della parola in questione nella nostra stringata conoscenza della lingua latina, procedendo per assonanze ed omofonie. Ecco, allora, che la “liquirizia” diventa la “cosa liquida”, il “succo” di una radice, anzi, viene ribattezzata anche “regolizia” per via della forma a “regolo”, ad asticella, barretta! La “salciccia” “carne - ciccia - salata”, in luogo del corretto “salsiccia” come “carne fatta a pezzi (da seco-as-secui-sectum-are) e salata”. Il mago esperto in magia nera ed evocatore di morti, da “necromante” (con il nekron per “morto” in greco) diventa “negromante”, data la generale convinzione per cui la magia nera sia tale in ragione di una sua provenienza dall’Africa, perché praticata dai Neri. Si profila così un inquietante davvero “evocatore di Vucumprà”! Ma cosa dire allora del “ciarlatano”, la |
| persona che “ciarla”, che racconta una marea di chiacchiere, termine coniato dal popolo ignorante in fatto di lingua, in luogo di un precedente e più corretto “cerretano”. Il “cerretano” era colui che proveniva in età medioevale da Cerreto di Spoleto e che si recava a Roma come questuante.Data la sua natura di questuante, parlava in abbondanza, proprio come ci spiega Bruno Migliorini, ed il suo troppo parlare ha spinto il popolo (che fa la lingua) ad adattare al significato di “grande parlatore” una più immediata forma linguistica, facilmente comprensibile da chiunque, quella di “ciarlatano”. Ciarlatano, liquirizia-regolizia, negromante e salciccia sono solo alcuni degli esempi di errate etimologie, di parole alterate dall’azione dei parlanti, che modificano la forma di una parola in nome del suo significato, anche per renderla più |  |
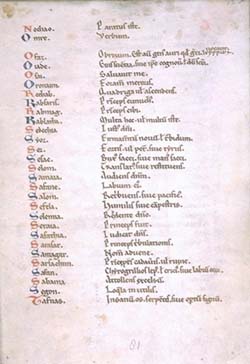 |
facilmente intuibile e comprensibile. Purtroppo queste parole (o meglio,
lessemi) sono entrate oramai nella nostra lingua corrente parlata, che
tempo addietro le alterò mediante l’azione dei parlanti ignoranti
(non ci sono eufemismi che tengano) ed hanno preso il posto delle loro
“gemelle corrette”.
Abbiamo dei sosia nella nostra lingua e non ce ne accorgiamo! Cerchiamo di prestare maggiore attenzione al nostro linguaggio ed alle nostre parole, anziché affidarci ad “illuminate intuizioni”, basate su un fare etimologia per associazioni mentali (“etimologia associativa:” la “salSiccia” è prima di tutto carne, ciccia salata. La ribattezzo “salCiccia”) o per “razionalizzazione metalinguistica”, scindendo una parola nelle sue componenti, in stringhe fonematiche o grafiche ed attribuendo a ciascuna il valore di parte di altra parola (ad esempio “armadio” da “arma-“ e “-dio”: “arma di dio”. Ma lo vedete Giove che scaglia armadi invece di saette?). È vero che la lingua la facciamo noi, ma di qui ad inventarcela mi pare troppo! Più attenzione! Massimo Blasi |

 |
Torna all' Home Page del sito
"Mameli on Web"
Torna alla pagina principale del sito di Murales |